I ricordi autobiografici si riferiscono alla storia della nostra vita, unica e irripetibile, sono dunque ricordi narrabili di eventi unici del proprio passato, prossimo e remoto.
Uno dei dubbi più frequenti che i pazienti portano in terapia è: “Non sono certa/o che questo evento o che questo particolare sia “vero” ma io lo ricordo così”. Quanto è importante sapere se un ricordo è autentico o meno? Rispondere a questa domanda è uno degli obiettivi di questo articolo.
“Se vogliamo sapere qualcosa di un uomo, chiediamo Qual è la sua storia, la sua storia vera intima?”, poiché ciascuno di noi è una biografia, una storia. Ognuno di noi è un racconto peculiare, costruito di continuo, inconsciamente da noi, in noi e attraverso di noi- attraverso le nostre percezioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni; e non ultimo, il nostro discorso, i nostri racconti orali. Da un punto di vista biologico, fisiologico, noi non differiamo molto l’uno dall’altro; storicamente, come racconti, ognuno di noi è unico. Per essere noi stessi, dobbiamo avere noi stessi- possedere, se necessario ri-possedere la storia del nostro vissuto. Dobbiamo ripetere noi stessi. L’uomo ha bisogno di questo racconto, di un racconto interiore continuo, per conservare la sua identità, il suo Sé”(Sacks, 1985; p. 153-154)
Il contatto con l’ambiente genera cambiamenti nel nostro sistema nervoso e altera il nostro comportamento per mezzo dell’apprendimento: possiamo definire questi cambiamenti ricordi. I ricordi non sono solo espressione del nostro apprendimento e cambiamento, infatti quelli che caratterizzano la memoria autobiografica sono custodi della nostra continuità e coerenza nello spazio e nel tempo, nonché della nostra unicità come individui attraverso la narrazione della nostra storia di vita. I ricordi autobiografici si riferiscono alla storia della propria vita, sono dunque ricordi narrabili di eventi unici del proprio passato, prossimo e remoto. Uno dei dubbi più frequenti che i pazienti portano in terapia è: “Non sono certa/o che questo evento o che questo particolare sia “vero” ma io lo ricordo così”. Quanto è importante sapere se un ricordo è autentico o meno? Rispondere a questa domanda è l’obiettivo di questo articolo.
Secondo molti studiosi della memoria, ed in particolare della memoria autobiografica, i ricordi non sono “verità autobiografiche”, ma in buona parte sono costruzioni della mente, nati per esprimere una verità psicologica piuttosto che oggettiva riguardo la vita della persona, e sono l’espressione di credenze sul sé e fantasie attorno alle quali si organizza la personalità del soggetto.
Ecco perché mentre raccontiamo la nostra vita raccontiamo molto anche di noi stessi e della nostra personalità, i ricordi sono infatti espressioni fenomeniche del Sé (Barclay), tanto che Beike et al. sostengono che l’espressione cartesiana del cogito ergo sum potrebbe essere ridefinita come io ricordo quindi sono.
La memoria autobiografica si può definire dunque come un sistema di memoria finalizzato ad una rappresentazione di Sè, ridisegnata in parte e narrata, con cui il soggetto cerca di costruire, comprendere e condensare, per sé stesso e per gli altri, la propria identità e il senso della propria vita (Leone, 2004). Il senso della nostra vita lo ricerchiamo infatti principalmente narrandoci. Proprio nell’atto della narrazione si organizza la memoria autobiografica, alla quale viene conferita struttura causale e temporale grazie al ragionamento autobiografico attraverso cui i ricordi sono integrati in modo coerente e unitario in relazione alla propria identità sociale e culturale, generando vere e proprie storie con le quali ci identifichiamo. Noi siamo la nostra storia, siamo “frutto” di quelle esperienze che sebbene nei nostri racconti, in parte, non siano fedeli al vissuto originale, ci forgiano e ci formano. Ecco perché questa riflessione sulla memoria autobiografica, che non solo ci consente di avere coscienza e salvaguardare la nostra identità e il nostro Sé ma ci consente anche di sviluppare capacità introspettive, abilità di regolazione, comunicazione e espressione affettiva. Tuttavia ciò può accedere solo se la narrazione avviene nel rispetto di alcune condizioni che fanno riferimento alle convenzionalità narrative, ovvero caratteristiche che vincolano chi narra a rispettare alcune regole di esposizione, le quali sono fondamentali per produrre una storia coerente e per stimolare il soggetto all’insight. Non è importante infatti come effettivamente andarono le circostanze, ma qual è il solco che esse hanno tracciato dentro di noi, sopratutto non è importante al fine della costruzione della propria identità la veridicità del ricordo, quanto invece risulta rilevante la coerenza della storia. In ogni caso il primo interlocutore è sicuramente lo stesso soggetto che racconta la sua storia, il quale diviene al contempo oggetto della narrazione e appunto soggetto narrante in una dinamica di doppia riflessività in cui “è il narratore a essere narrato” e a riconoscersi nella storia (Fivush, Haden, Reese ,1995) .Ripercorrere “quelle strade” è un modo per viaggiare dentro il nostro Sé e conoscerlo, ma anche un modo per riallacciare quei “fili interrotti” dell’esistenza, per cercare significato a ciò che si è vissuto, per maturare. L’ordine narrativo sarà definito dal percorso disegnato dalla nostra memoria e ci accorgeremo che a prevalere saranno quegli avvenimenti colorati di emozione, poiché è proprio l’emozione che connota il ricordo. Quando un individuo rievoca un ricordo autobiografico, infatti fa sì che le emozioni provate durante l’esperienza realmente vissuta e le emozioni provate durante la narrazione della stessa si combinino, non solo, l’accezione conferita al ricordo e la sua valenza positiva o negativa sono strettamente connessi ai tratti di personalità di colui che se ne fa portavoce. In aggiunta narrare le proprie esperienze negative a sé stessi o raccontarle ad un interlocutore empatico e che ascolta attivamente, aiuta a lenire ciò che angustia e contribuisce a dare sollievo, mentre narrare le proprie esperienze positive conferisce al ricordo maggiore intensità emotiva. La rievocazione del ricordo congiunto è un mezzo attraverso cui fin dall’infanzia il genitore favorisce nel bambino lo sviluppo del pensiero narrativo, fondamentale poi in tutto l’arco della vita, in quanto consente di promuovere la creazione di legami sociali, la consapevolezza di sé e di sviluppare capacità empatiche. L’alone emotivo dei ricordi che vengono condivisi, ha poi il “potere” di avvicinare dal punto di vista affettivo le persone che ricordano insieme. Quindi dei ricordi non possiamo fare a meno nella costruzione di quelle storie che danno forma e significato alla nostra vita, che ci tengono uniti o separati e che contribuiscono a costruire il nostro Sé e la nostra identità. In linea con questa teoria negli ultimi decenni in ambito clinico si è diffuso un approccio che indaga la relazione tra memoria autobiografica e funzionamento della personalità o Sè: Il paradigma delle “Self defining memories” (SDM) (Singer,2004), quei ricordi che secondo Singer (2005) ci aiutano a definire e spiegare agli altri chi siamo. Le self defining memories sono ricordi specifici, particolarmente rilevanti nella storia di vita del paziente, evocati in maniera spontanea, che permetterebbero di identificare caratteristiche di personalità dello stesso e ne consentirebbero l’analisi delle relazioni con le persone significative. Studi recenti hanno dimostrato inoltre che la capacità di dare senso alle proprie self defining memories e di integrarle è predittivo del grado di autostima del soggetto, del senso di benessere e della qualità della vita. Ciascuno di noi ha bisogno infatti di agganciare le proprie esperienze in life stories, perché siamo tutti alla ricerca di coerenza, di continuità nel tempo e nello spazio nonostante i continui cambiamenti ai quali siamo inevitabilmente soggetti.
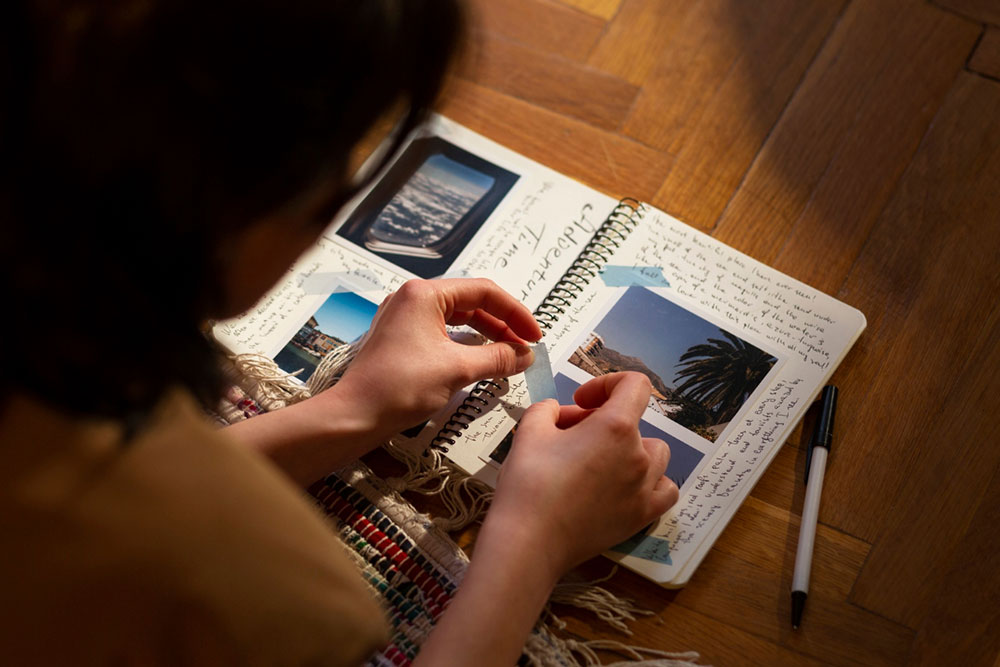
Ora la questione che sorge spontanea è: “Fino a che punto la vita è riuscita a cambiarci con le sue continue sfide evolutive, previste e inattese, e fino a che punto invece sempre in relazione ad esse restiamo gli stessi, anche se in apparenza diversi?”. Il tema dell’identità è al centro di questo spunto di riflessione, il quale rimanda ad aspetti di continuità come anche di cambiamento, in proposito Serino (2000) rappresenta l’identità come “àncora o gabbia”, proprio considerando quelle sensazioni, ora di angoscia nel sentirsi “chiusi in un’identità che ci sta stretta”, ora di conforto nel percepirci in una sintesi che ci protegge dal rischio di perdere noi stessi. Anche Neisser (1988) aveva colto questi aspetti per certi versi opposti nel tema di sé e dell’identità, teorizzando il concetto di estensione temporale (di cui fanno parte), secondo cui alla base della memoria autobiografica c’è sempre un movimento temporale della soggettività, un confronto tra ora e allora. La “teoria sul Sé”, di cui un individuo è portavoce, infatti non solo influenza la visione che avrà del suo passato, ma anche la sua prospettiva di azione futura, e quindi l’insieme di motivazioni, intenzioni ed atti che prenderanno corpo nel suo progettare il proprio avvenire. Ecco perché la memoria del passato si configura come espressione del presente e proiezione del futuro. In definitiva come sostiene Shacter per comprendere il presente e prevedere il futuro bisogna essere capaci di comunicare con il passato, quando perdiamo questa capacità che ci consente di viaggiare nel tempo è come se ci staccassimo da tutto ciò che riguarda il nostro Sé e perdessimo la nostra identità. Lo scambio di ricordi che la memoria autobiografica ci permette attraverso la loro narrazione infatti consente di capire meglio ad ogni persona, prima di tutto sé stessa, concependo la propria peculiarità e irripetibilità, ma anche che può esistere qualcosa che unisce nell’affrontare le sfide che la vita propone, qualcosa che ci avvicina nonostante le diversità delle quali è portavoce. La memoria autobiografica dunque coincidendo con il bisogno di identità si caratterizza ulteriormente come manifestazione dell’esigenza di dare al nostro esistere l’ulteriore e fondamentale accezione di vissuto, attraverso la storia che solo ognuno di noi può raccontare.
Ecco perché anche nel lavoro clinico è fondamentale conoscere la storia di vita delle persone: perché solo attraverso quest’ultima è possibile conoscere ed entrare nel mondo interno di chi abbiamo di fronte, dare significato alla sofferenza che porta e aiutarlo/a nel modo più individualizzato possibile.

